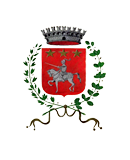La bassa pianura vercellese (e ancor di più la zona di Baraggia) non è perfettamente pianeggiante. Digrada lentamente da nord-ovest verso est, sud-est. Si va dai 160 metri sul livello del mare nei pressi di Crescentino e poi, poco più a est del canale Cavour, ai 150 metri nei pressi di Lucedio e Lachelle; ai 140 di Tricerro; ai 130 di Trino, Costanzana e la stessa Vercelli. Fino ai 120 metri di Stroppiana e Caresana e ai 110-100 della confluenza Sesia-Po. Tutto l’intricato sistema di canalizzazione vercellese ha sfruttato opportunamente queste lievi pendenze e le risaie hanno fatto altrettanto.
Una camera di risaia non può essere in pendenza se si vuole evitare che l’acqua scorra via senza essere trattenuta. Deve essere perfettamente in piano. Proprio per garantire questa perfezione si sono via-via adottate tecniche diverse, fino alle sofisticate livellatrici al laser.
Per garantire una distribuzione uniforme dell’acqua senza ristagni, dentro la camera di risaia non devono esserci avvallamenti, buchi o depressioni. La superficie deve essere piatta come un biliardo (almeno questo è il tentativo). Ma come si può garantire una superficie piatta in presenza di una pendenza, seppur lieve? Si ricorre all’antichissimo metodo del terrazzamento, utilizzato dagli albori dell’agricoltura in tutti i terreni montuosi e collinari. Si spianano porzioni di terreno, proteggendole a valle con terrapieni. Lo stesso si fa per quelle successive. Il risultato è un paesaggio che per il vercellese sembra fatto di tanti stagni coltivati delimitati da semplici argini, ma che ad uno sguardo più attento rivela invece un ampio sistema di gradoni che indicano da quale parte pende la pianura.
È quindi logico pensare che le camere di risaia digradano seguendo le curve di livello nella direzione che abbiamo detto, fino alla confluenza Sesia-Po. In realtà, in questa lieve discesa, c’è una moltitudine di depressioni localizzate. Per esempio, in presenza di torrenti di origine risorgiva che hanno scavato sia pur lievemente il loro letto nei sedimenti planiziali, come la Marcova o la Bona, le risaie cambiano direzione di pendenza. Digradano verso il solco vallivo creato dal torrente e non verso sud-est. Lo stesso vale per deboli rilievi e zone di depressione lasciati dall’azione del Po o del Sesia o tutto intorno alla collina della Partecipanza.
Visto che l’acqua deve riempire tutta la camera e deve scolare in quella successiva, le camere sono solcate da piccoli fossi a pettine che hanno il compito di distribuire l’acqua e di farla scolare. L’acqua arriva dal canale nella prima camera attraverso la bocchetta di ingresso. La bocchetta a valle, collegata a quella di ingresso con un solco acquaio che favorisce lo scorrimento, riversando l’acqua nella camera successiva. Le camere sono perimetrate dagli argini. E tutto il complesso dell’appezzamento ha a sua volta argini più robusti, strade di servizio e soprattutto le canalizzazioni che, aperte e chiuse, di volta in volta, servono per allagare e raccogliere le acque di scolo a seconda della loro posizione rispetto alla risaia. Così, prima della preparazione colturale, la risaia deve subire la sua peculiare sistemazione in funzione idraulica.
Tutte queste pratiche, oltre che servire a livellare, hanno anche lo scopo di compattare entro certi limiti il terreno per diminuire le perdite d’acqua. Il terreno, così meticolosamente preparato per l’arrivo dell’acqua, con la sommersione subisce mutamenti chimico fisici che rafforzano l’impermeabilizzazione della camera. Le particelle fini riempiono gli interstizi tra quelle più grossolane sul fondo della camera e dei solchi. Naturalmente questo è più facile che avvenga nei terreni argillosi. In quelli più sabbiosi sono necessarie vere operazioni di costipazione del terreno e la quantità d’acqua persa è maggiore.